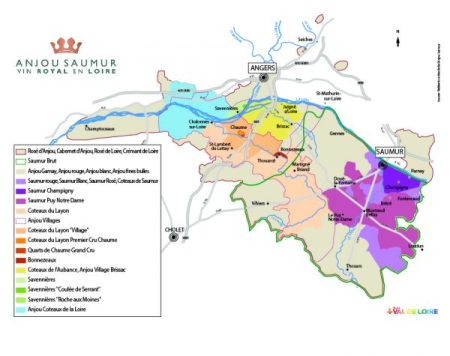E’ stata una bellissima esperienza umana nonché di crescita professionale guidare la Masterclass¤ di Aspi Campania tenuta a Pozzuoli in collaborazione con il Consorzio ViTiCa, ente che Tutela i Vini D.O.C. Falerno del Massico¤, Asprinio di Aversa, Galluccio e le I.G.T. Terre del Volturno e Roccamonfina.

La storia ci ha sempre raccontato che il Falernum già in epoca romana veniva considerato vera e propria rarità enologica tanto dall’essere addirittura riconosciuto con ben tre sottodenominazioni a seconda della sua provenienza geografica. Era chiamato comunemente vinum Falernum tutto quello prodotto nell’Ager ma generalmente da vigne allocate in pianura; il Faustianum invece era quello tralciato nell’area appena pedecollinare mentre veniva riconosciuto Caucinum solo quello più prezioso, proveniente dall’alta collina.
A seconda poi delle caratteristiche organolettiche che tali vini esprimevano, vi era anche una distinzione per tipologia del tipo Austerum per i vini austeri e/o astringenti, Dulce se appunto dolci o Tenue quando leggiadri e beverini. Parliamo certamente di vini che avevano ben poco a che vedere con l’odierna qualità espressa in terra di Falerno, ma la particolare attenzione riservata a questo vino ci suggerisce quanto queste terre fossero già allora vocate alla viticultura e, per i palati di allora, apprezzati i vini qui prodotti.
Oggi, pur avendone ben chiari i confini della doc Falerno del Massico non è affatto semplice riassumerne per intero una zonazione efficace di tale territorio che, oltretutto, gravita attorno al massiccio del Monte Massico facendo sì che si passi da terreni pedemontani a collinari – con tutte le implicazioni pedoclimatiche, ndr -, sino ad arrivare letteralmente al mare. Alcuni riferimenti che possono però aiutarci a comprendere meglio ciò che provano a raccontare certe bottiglie che vanno in giro ci teniamo comunque a precisarli.
Nell’areale di Sessa Aurunca insistono circa 78 ettari denunciati alla doc, coltivati prevalentemente con Aglianico, Piedirosso, Falanghina e Primitivo; qui i terreni sono generalmente caratterizzati da tufo nell’interno, verso il vulcano spento di Roccamonfina e sabbia e limo verso la costa sino al mare.
Cellole conta 25 ettari coltivati con Aglianico, Piedirosso, Falanghina, Primitivo, qui i terreni sono sostanzialmente caratterizzati da sabbia e limo con alcuni tratti di origine alluvionale.
A Carinola e nei suoi dintorni insistono 26 ettari piantati con Aglianico, Piedirosso, Falanghina, qui il vigneto sembra essere più omogeneo su tufo e argille.
Falciano del Massico il vigneto doc conta circa 13,5 ettari votati a Primitivo, Barbera, Piedirosso, Falanghina, Moscato con terreni frammisti di argille, crete e limo, sabbie.
Infine Mondragone, con i suoi 8,5 ettari di Primitivo e Falanghina e le sue vigne che diradano sino a due passi dal mare, qui i terreni sono composti perlopiù da limo, sabbie con misto argille.

Una terra straordinaria quindi l’Ager Falernus che oggi potremmo così definire: di qua, a partire da sud-ovest, Mondragone, Falciano e, verso nord-est, Carinola. Di là, a nord, Cellole e poi Sessa Aurunca con le sue frazioni di Carano e Cascano verso est che si spingono fin su il vulcano spento di Roccamonfina. Ad ogni modo un territorio tutto da scoprire, da bere, ricordare a cominciare da questi sette nomi…
Falerno del Massico bianco Aurunco 2018 La Masseria di Sessa. Una piacevole scoperta questa splendida realtà del comune di Sessa Aurunca. In linea con i principi di produzione naturale qui il vino biologico viene prodotto in maniera rigorosa a partire da frutti sani e ricchi di materia viva, una coltivazione senza ammendanti chimici, utilizzando per i terreni solo compost aziendale, fino ad un processo di trasformazione che abbina gli antichi metodi con una modernissima tecnica di pressatura che utilizza gas naturale per l’estrazione del mosto tale da consentire la riduzione, e in alcuni vini, la totale assenza dell’utilizzo dell’anidride solforosa. E’ un Falerno nuovo, affianca alla Falanghina un piccolo saldo di Fiano, è luminoso, ampio al naso, caratterizzato dal candore del debuttante ma con tanta buona materia dentro. Farà la sua strada.
Falerno del Massico bianco Vigna Caracci 2016 Villa Matilde Avallone¤. La storia di Villa Matilde comincia negli anni Sessanta con Francesco Paolo Avallone, avvocato e appassionato cultore di vini antichi, che, incuriosito dai racconti di Plinio e dai versi di Virgilio, Marziale ed Orazio sul vinum Falernum, decise di riportare in vita il leggendario vino scomparso al principio del secolo scorso. Dopo anni di studio, individuò le viti che avevano dato vita al Falerno in epoca romana: pochi ceppi sopravvissuti miracolosamente alla devastazione della fillossera di fine Ottocento vennero così ripiantati, con l’aiuto di pochi contadini locali, proprio nel territorio del Massico, dove un tempo erano prosperati e fondò Villa Matilde.
Oggi l’azienda è guidata dai figli di Francesco Paolo, Maria Ida e Salvatore Avallone che con dedizione esclusiva proseguono il sogno e il progetto del padre raccogliendone l’importante eredità guardando ancora oltre. Vigna Caracci duemilasedici è il Falerno bianco, espressione di questo territorio che trova nella sostenibilità e nella ricerca la sua forza e la sua proiezione. Ha un colore oro luminoso, il naso è intriso di tante piacevole sensazioni balsamiche, fruttate, floreali, melliflue, con quel sorso sferzante e caparbio, sapido e lunghissimo.
Falerno del Massico rosso 1880 2016 Bianchini Rossetti¤. La famiglia Rossetti è qui da oltre tre generazioni, l’azienda produce oggi Falerno del Massico con le uve di proprietà provenienti perlopiù dalla collina di San Paolo, nel cuore di Casale di Carinola. In prima linea da circa un ventennio ci sono Tony Rossetti e l’instancabile Zio Francesco, artefici dell’ultimo rinnovamento aziendale. La filosofia è semplice e chiara: produrre vini di qualità nel rispetto del territorio. Non ricordiamo di questo vino una sola sbavatura, giunti alla decima annata assaggiata con il duemilasedici ci appare sempre in grande forma, dal colore rubino vivace e con un naso fierissimo, pieno di sottili sfumature che fanno dei due varietali Aglianico e Piedirosso espressione unica di questa terra!
Falerno del Massico Primitivo Conclave 2017 Gennaro Papa¤. Produttori storici a Falciano del Massico, nel versante che guarda a sud del Monte Massico, fin dal 1900 promuovono la coltivazione del vitigno Primitivo oltre al moscato e ad altri vitigni minori poi ammessi nel disciplinare doc nel 1988. Dal 1999 iniziano gli imbottigliamenti e la commercializzazione del Falerno del Massico doc Primitivo e la valorizzazione dei vitigni storici coltivati sulle colline a 300 mt s.l.m. e contestualmente iniziano un lavoro di ricerca assiduo che da nuova linfa al territorio e alla viticultura dell’areale. E’ un gran bel bere il vino di Antonio Papa, profondo e suggestivo, nel colore, nei profumi straordinariamente originali e nel sapore secco, morbido, caldo, avvolgente, sapido. Ne torneremo a raccontare più dettagliatamente.
Falerno del Massico Primitivo Primo Antico 2017 Cantina Trabucco. L’azienda di Nicola e Danilo Trabucco nasce nel 2003 nel piccolo comune di Carinola, alle pendici del Monte Massico con l’obbiettivo di produrre vini territoriali di pregio che possono esprimere in tutta la loro pienezza, la forza e l’eleganza del territorio d’origine. Primo Antico duemiladiciassette nasce con una idea precisa, quella di avvicinare al Falerno massicano bevitori seriali e a guardare il risultato nel bicchiere ci appare un messaggio chiaro ed inequivocabile, oltre che vincente!
Falerno del Massico rosso Etichetta Bronzo 2013 Masseria Felicia¤ – Sessa Aurunca. Camminare a passi lenti e brevi tra i filari e lasciarsi cogliere da un sorriso, quasi una smorfia della bocca che si trasforma in mezzaluna, e illuminare l’aria. Questa semplice azione che poi si è trasformata in abitudine, è quella che ha spinto Maria Felicia a viverci tra queste vigne e questi uliveti. Collocata alle falde del Monte Massico, eccoci dinanzi ad un Falerno del Massico di antica tradizione e nuova identità. Etichetta Bronzo duemilatredici è un rosso meravigliosamente squadrato, dal colore rubino profondo con delicate sfumature di alleggerimento sull’unghia del vino nel bicchiere. Il naso è ricco, subito verticale, parte sfrontato, accigliato, speziato, poi viene fuori l’amarena, la prugna, sentori di tabacco. Il sorso è slanciato, perentorio il tannino, tanto è caparbio che ti sembra quasi di masticarlo, ma lo perdi tra un morso e l’altro del frutto polposo e gaudente.
Falerno del Massico rosso E’ 2015 Torelle. L’azienda della famiglia Guardascione nasce nel 2009 con l’acquisto dei terreni, in località Torelle nel comune di Sessa Aurunca per intuizione di Emanuele. Era un agronomo e la sua più grande passione era la viticoltura. Dopo la laurea in agraria iniziò il suo percorso, prima con Pierpaolo Sirch presso Feudi San Gregorio, poi per qualche anno presso l’azienda cilentana De Conciliis. Nel 2010 piantò i primi 2,5 ettari di Aglianico e nel 2014 rilevó una piccola cantina nella frazione di Cascano, sempre nel comune di Sessa Aurunca, dove portò a termine la sua prima vendemmia allorché venne a mancare prematuramente all’età di soli 29 anni.
Giuliana, la sorella, a cui Emanuele ha provato a consegnare il testimone nonostante il troppo poco tempo a disposizione, ha subito raccolto con grande slancio l’eredità del fratello e continua a metterci l’anima nel portare avanti il loro sogno, rinverdire i fasti del Falerno. L’azienda produce oggi circa 12.000 bottiglie di vino con uve provenienti da vigneti coltivati in biologico proprio a ridosso del vulcano spento di Roccamonfina. Falé duemilaquindici non è ancora in commercio, è un Falerno dal sapore ancestrale, vivace e sfrontato al naso, vinoso, floreale, fruttato, quanto sottile e saporito al palato. Ci ha aperto gli occhi su un’altra splendida realtà dell’Ager da tenere d’occhio nei prossimi anni. Ci torneremo su.
Leggi anche Piccola guida ai vini Falerno del Massico Qui.
© L’Arcante – riproduzione riservata